Ravenna, il caso di Arijon che provò quattro volte a fuggire dall'Albania

Barbara Gnisci
A raggiungere l’Italia dall’Albania, Arijon Abdyli, oggi residente a Ravenna, ci ha provato quattro volte. La prima fu proprio nel ‘91, l’anno dei primi sbarchi: «Partimmo da Durazzo con destinazione Bari. Eravamo 18000 albanesi sulla nave Vlora, diventata poi simbolo dell’esodo. Era l’8 agosto, salpammo nel pomeriggio impiegando più di 24 ore ad arrivare. Faceva un caldo impressionante, mancavano l’acqua e l’aria. Fu un viaggio terribile». Arijon, oggi 50enne, allora aveva da poco avuto la prima figlia, rimasta con i nonni, quando intraprese quell’avventura infelice, senza un buon esito: «Chi parte, fugge da una povertà estrema e da una condizione di reale rischio per la propria vita. Nessuno lo fa se non è costretto da uno di questi motivi, che poi sono la stessa cosa, perché essere poveri significa non riuscire a sopravvivere, non potersi curare, non avere cibo. Questo capita quando la tua parola conta zero, anche se ti dicono che è democrazia, ma non lo è affatto. L’Albania veniva da un regime terribile. Appena era caduto, si erano aperte le porte di ingresso per l’Europa, ma per noi erano rimaste chiuse. L’unica via di uscita era arrivare da clandestino, rimanere in Albania equivaleva a non avere nessun futuro». Arijon tenta di raggiungere chi era partito qualche mese prima, come suo fratello: «Appena sbarcati, ci hanno chiuso nello stadio di Bari: senza regole, senza nessun intervento, senza soccorso. Ognuno aveva la propria di regola, la sopravvivenza. Sono state altre 24 ore di sofferenza, di caldo estenuante. Eravamo stremati. Non potevamo comunicare con nessuno, C’erano donne incinte, bambini, anziani». Il giorno dopo la cattiva notizia: «Ci hanno fatto espatriare, ritornare da dove eravamo partiti. Il viaggio di ritorno lo abbiamo fatto con l’aereo. Non so spiegare il senso di amarezza e di delusione di quel volo durato solo 20 minuti. La gente non mette a rischio la propria vita e quella dei propri cari se non per una necessità estrema. Ho sempre sentito molto forte la rabbia per il regime comunista e quando cominci a sentire l’odore di libertà è inevitabile sognare la tua vita in un altro paese». Arijon ci riprova nel ‘97, questa volta anche con sua figlia che ormai ha 6 anni: «Pochi mesi prima era scoppiata la guerra civile ed eravamo pronti a correre rischi per andare via. Ci abbiamo provato con un motoscafo. Eravamo una cinquantina di persone e c’erano dodici bambini. Siamo arrivati fino al canale di Otranto, ma a causa del cattivo tempo siamo stati costretti a tornare indietro. Il giorno dopo le condizioni atmosferiche erano favorevoli e allora ci abbiamo provato un’altra volta. A un certo punto abbiamo visto una nave militare italiana che ci seguiva e che ci illuminava. Si sono avvicinati più e più volte e avevamo paura, perché stava ostacolando il nostro percorso. Non ci sentivamo sicuri. Questa volta c’erano solo sei bambini. Abbiamo deciso di tornare indietro». Una volta a Durazzo, Arijon e i suoi compagni di viaggio apprendono alcune notizie in tv: «Tutti i telegiornali italiani parlavano del nostro inseguimento. La mattina dopo, invece, abbiamo saputo della tragedia. La stessa nave militare che aveva inseguito noi, dopo che noi eravamo tornati indietro, si era avvicinata a una nave di albanesi e l’aveva sfondata. È stata una grande tragedia. Quella mattina stessa siamo partiti per la terza volta consecutiva, ben consapevoli che nessuno ci avrebbe ostacolati, anzi la guardia costiera ci ha scortati fino a Brindisi. La gente che non l’ha vissuto non può immaginare che cosa significhi sapere di avercela fatta, quando altri, molto vicini a te, lo stesso giorno, hanno perso la vita. È stato un viaggio doloroso. Non si può chiamare clandestino uno che arriva rischiando la propria vita e quella dei propri figli, che paga per correre quel pericolo. Sono delle persone senza diritti». Gli ultimi metri di quel viaggio, Arijon e i compagni, li fecero a mollo nell’acqua a causa degli scogli: «Passammo la notte in un terminal portuale, poi ci trasferirono nello stesso centro di accoglienza dove c’erano i sopravvissuti della notte prima. Sentimmo dei racconti angoscianti. Un ragazzo ci raccontò che stava viaggiando con suo cugino e la sua famiglia. Quando la nave cominciò ad affondare, lui rimase in coperta, mentre il padre di famiglia cercava di raggiungere la moglie con la bimba che erano sotto. Non salì più nessuno. Morirono tutti. La neonata aveva due mesi. C’erano ragazzi che fino a poco prima erano stati pieni di vita e di sogni e ora quello che rimaneva nei loro occhi era solo dolore e paura. Dopo poche ore arrivò mio fratello che, con un regolare permesso di soggiorno, ci portò a Cervia a casa sua, dichiarando che ci avrebbe ospitato. Non ci si riprende mai da un episodio così. Soprattutto perché non ha mai trovato giustizia. La tragedia di quella nave e i racconti di quei ragazzi mi accompagneranno per tutta la vita».
 13:48
13:48 Nuvoloso
Nuvoloso  Accedi/Registrati
Accedi/Registrati


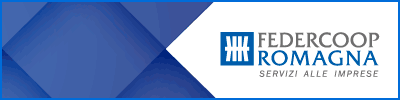















 Torna indietro
Torna indietro 29/03/2021 - Agron Bushi
29/03/2021 - Agron Bushi












































