All’esame di maturità il presidente di commissione Scevola Mariotti, coautore del vocabolario IL, legge il suo tema e vuole conoscerlo. Si iscrive alla facoltà di lettere classiche dell’università di Bologna e Lucrezio è l’oggetto della tesi di laurea da discutere il 5 Novembre del ʼ72. Un giorno il relatore lo chiama e gli dice: «Lei Dionigi si laureerà il 26 ottobre. Venga il primo novembre in università, sarà mio assistente». Così comincia la carriera universitaria di Ivano Dionigi, professore prima alla Ca’ Foscari di Venezia e poi all’Università di Bologna, di cui nel 2009 diventa Magnifico Rettore.
Il 29 ottobre 2018 è stato nominato professore emerito: ora che è in pensione si sta finalmente godendo l'otium, oppure le manca un po' il negotium?
«A differenza di altri lavori dove c’è una netta cesura fra la militanza e la pensione, io non ho avvertito nessuna frattura, nessun passaggio. C’è sempre stata un’identificazione fra professione e passione. Anche adesso passo le mie giornate a studiare, a scrivere e a divulgare il pensiero dei classici soprattutto ai giovani. Da quando sono formalmente in pensione, ho incontrato circa 16mila giovani in 97 convegni. Prima ho fatto politica in consiglio comunale per 14 anni, però ho l’impressione che la politica vera la stia facendo ora. Adesso ho una gran fortuna, ho più tempo libero per pensare e questo qualche volta è anche un problema».
Perché leggere i classici?
«Perché i classici sono ansiosi di capire come stanno le cose depurate di ogni apparenza e soprattutto primeggiano in quella che io chiamo l’ars interrogandi. La forza dei classici è che resistono ai tempi e alle mode perché i problemi nella vita sono sempre gli stessi: trovare la propria strada, il dolore, l’amore, la morte, il rapporto con gli altri, la politica. La differenza fra un classico e un non classico non è nel che cosa, ma è nel come tratta i problemi, non è solo una questione di contenuti ma anche di forma. La parola non è il recipiente del pensiero, ma è un tutt’uno con il pensiero. Soprattutto oggi, in questo periodo della chiacchiera imperante, dove le persone blaterano ma sono mute, il problema non è parlare ma dire. Il pensiero tecnico-scientifico ha il paradigma della sostituzione e della dimenticanza. Invece il pensiero umanistico, letterario e filosofico vive sul paradigma del cumulo, della memoria. Noi abbiamo bisogno di un pensiero lungo. Bisognerebbe che tutti gli scienziati conoscessero il pensiero filosofico e che tutti i filosofi conoscessero la scienza. C’è il pregiudizio che la tecnica e l’economia servono, mentre la letteratura e la filosofia non servono perché sono astratte. Socrate è colui che ha strappato la filosofia dal cielo e l’ha portata nelle città, nelle case e dentro ognuno di noi. La filosofia è la cosa più concreta, perché è cura della ragione, del logos, che riguarda tutti. È vero che noi abbiamo il problema di prendere l’autobus, di far tornare i conti, di trovare un mestiere, però oltre alla gestione quotidiana delle nostre vite, ognuno di noi si chiede che cosa stia a fare al mondo».
Lei finora ha pubblicato esclusivamente saggi e articoli, ha mai pensato di cimentarsi del ruolo di romanziere?
«Sarei tentato di non rispondere a questa domanda perché ho avuto un’infanzia particolare con episodi non comuni di felicità e anche di tragedia. Quando li ho raccontati alcune persone mi hanno sollecitato a scrivere un romanzo, ma finora ho resistito un po’ per pudore, un po’ perché credo di avere la cifra del saggio, della forma breve, della sentenza senecana».
Qual è il rapporto fra saggistica e narrativa? E fra filosofia e letteratura?
«Mi trovo più a mio agio quando leggo Lucrezio o Seneca di quando leggo dei romanzi. Leggere dei poeti mi piace però al dulce preferisco sempre l’utile e mi pare che la filosofia appartenga più alla categoria dell’utile, la letteratura un po’ più al dulce. Ho l’impressione che il saggio parli più direttamente a me di me. Nella letteratura c’è più mediazione, c’è l’invenzione, c’è la metafora. Però invidio molto chi sa scrivere bene, soprattutto chi sa scrivere poesie, perché per ogni problema c’è la parola necessaria e fortunato è chi la scopre. Un libro che amo su cui torno spesso è la Bibbia, perché la Bibbia è narrativa ma soprattutto è sapienziale».
Ha detto che la Bibbia è una delle sue letture preferite: si definisce un credente?
«Il tema religioso mi interessa molto. Credente è il participio presente del verbo credere. Sto con il cardinale Martini, che alla distinzione fra credente e non credente preferiva quella fra pensante e non pensante».
«Segui il tuo demone» è il titolo del suo ultimo libro: saprebbe dare una definizione di demone e qualche consiglio su come trovarlo?
«Anzitutto bisogna partire dal presupposto che è una compagnia che non ti rende tranquillo, perché è la voce dell’alterità. Solo gli animali sono tranquilli. Siamo irripetibili, ognuno è diverso dall’altro e ognuno deve trovare la propria strada, chiedersi quali sono le sue possibilità e attese e deve fare di tutto per soddisfarle, altrimenti rimane una persona frustrata. Ciascuno deve capire cos’è il bene per lui, tenendo presente che questa è l’unica via per potersi almeno accostare alla felicità (per i greci eudaimonìa). Inoltre bisogna acquisire la convinzione che la felicità non è un problema privato: o lo siamo tutti o non lo è nessuno, perché se il mio vicino di casa è infelice io non posso essere felice. Tessendo ognuno il filo del proprio demone, dobbiamo costruire la tela comune della politica, un tappeto su cui ci potremo sedere tutti assieme, perché noi siamo chiamati o condannati a vivere nella polis. Chi vive fuori dalla comunità o è bestia o è dio. Il volto dell’altro introduce sempre una dimensione di verità, perché ci ridimensiona, ci fa capire quanto siamo forti, quanto deboli, quanto possiamo e quanto non possiamo fare. Bisogna cercare di rispondere quotidianamente alla domanda di Agostino: ma tu chi sei?».
 18:48
18:48 Nuvoloso
Nuvoloso  Accedi/Registrati
Accedi/Registrati


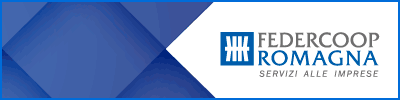















 Torna indietro
Torna indietro












































