IL CASTORO | Il turismo «spaziale», magnifica opportunità o seduzione ultracapitalistica?

Giulia Rosetti
Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. La tecnologia aerospaziale negli ultimi 52 anni si è sviluppata enormemente e le esplorazioni del cosmo sono in continuo aumento, soprattutto quelle di privati statunitensi. Inoltre, grandi imprese come la «Space X» di Elon Musk, la «Virgin Galactic» di Richard Branson e la «Blue Origin» di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si stanno mobilitando per promuovere una nuova tipologia di turismo spaziale. Nel febbraio 2020 l’imprenditore americano Elon Musk ha stretto un accordo con l’impresa turistica aerospaziale «Space Adventurous», decidendo di inviare i primi turisti nello spazio nel corso del 2021. Il magnate della Tesla, convinto sostenitore della multi-planetarietà della specie umana, ha pianificato di spedire i primi coloni su Marte entro il 2030. Il progetto consiste nello sviluppare una navicella spaziale, all’insegna del comfort, che permetta ai coloni di arrivare in forma su Marte nonostante gli 8 mesi di viaggio. La struttura del razzo, molto simile a quella delle navicelle raffigurate nei cartoni fantascientifici degli anni ‘70 e ‘80, permetterà ai coloni di godersi il panorama spaziale attraverso una grande vetrata.
«Riprodurre e vendere sogni facendo leva sui ricordi d’infanzia di un’intera generazione», ecco ciò che tenta di fare l’imprenditore americano secondo l’ingegnere faentino Marco Peroni, autore di un progetto dal titolo Abitare lo spazio, che punta a creare celle abitative su Marte. Allo stesso tempo Guido Sarchielli, professore emerito di psicologia dell’Università di Bologna, afferma che l’intento di Elon Musk sia far leva sul bisogno comune dell'essere umano di superare i propri limiti per sentirsi totalmente realizzato, stimolando così la «ricerca del brivido», di cui ogni individuo sente il bisogno. Il fascino dell’ignoto e la soddisfazione della concretizzazione di un sogno d’infanzia sono gli aspetti che rendono ancor più interessanti i progetti di Elon Musk.
Ma le ambizioni di tutte queste aziende private rappresentano realmente una risorsa per l’umanità? Il professor Sarchielli teme che un’eccessiva commercializzazione dello spazio possa portare a una forma di capitalismo smisurato, dannoso e non democratico. D’altra parte - riflette Peroni - «è proprio grazie alla competizione formatasi che i costi delle esplorazioni sono calati, permettendo uno sviluppo tecnologico molto più rapido». Basti pensare che il costo di una base lunare permanente si aggira attorno ai 20-30 miliardi, l’equivalente circa delle spese militari annuali italiane (25 miliardi). Per paesi sviluppati come gli Usa, le cui spese militari ammontano a 500 miliardi l’anno, non si tratta di cifre esorbitanti. L'avvento dei privati nello scenario aerospaziale ha anche portato un incremento dei finanziamenti e una conseguente rapida crescita delle esplorazioni e dei progetti, spesso con budget superiori a quelli statali. L’irruente corsa allo spazio di Elon Musk ha destato non poche perplessità. C’è chi, come l’ingegnere Peroni, afferma che «il progetto di Musk sia ambizioso, ma non per questo irrealizzabile». Peroni auspica che le norme attualmente in vigore a tutela della collettività dello spazio siano sufficienti per evitare uno scontro tra potenti aziende. Altri invece, come ad esempio il professor Sarchielli, si mostrano più critici nei confronti dell’imprenditore americano, ribadendo che l’unico strumento per evitare la creazione di un dannoso mercato capitalista spaziale sia la regolazione democratica del fenomeno attraverso norme chiare ed efficaci, prendendo in considerazione ciò che è eticamente corretto ed evitando la creazione di pericolosi legami di convenienza.
 01:21
01:21 Nuvoloso
Nuvoloso  Accedi/Registrati
Accedi/Registrati


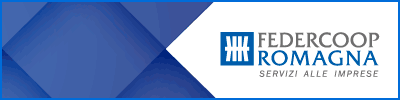















 Torna indietro
Torna indietro












































