Ravenna, parla Morelli, ex direttore Ps, a due anni dal Covid: "In una settimana ci siamo visti travolgere"

Federica Ferruzzi
Andrea Morelli è l’ex direttore del pronto soccorso di Ravenna, colui che, insieme ai colleghi, ha fatto fronte ad una situazione mai vissuta prima di due anni fa inventando, all’occorrenza, anche risposte pratiche per isolare i malati di Covid. E’ stato il primo ed unico medico, nella storia del Santa Maria delle Croci, ad attivare il piano di evacuazione dell’ospedale nel momento di massima affluenza. «Una decisione di cui non mi sono mai pentito - spiega oggi, in pensione -: c’erano 80 persone in attesa su altrettante barelle che necessitavano di una risposta e non c’erano spazi».
Ma cosa rimane di questi due anni di pandemia?
«Noto che oggi l’attenzione da porre ad un nuovo modello di comportamento obbliga tutti ad essere un po’ più civili. Inoltre la pandemia ci ha costretti a riprendere insegnamenti che avevamo dimenticato, come il rimanere a casa se si ha la febbre e lo stare in convalescenza dopo la malattia, cose che dovremmo avere imparato, ma che nella furia di produrre avevamo dimenticato. Forse la gente ha anche imparato ad usare le mascherine quando passerà il Covid e i timori saranno meno. Solitamente questo tipo di pandemia trova il modo di essere arginata, ma il Covid continua a mutare. Certo è che se si superasse il 94% dei vaccinati non ci sarebbe neanche più l’obbligo di fare tamponi».
Com’era la situazione all’inizio?
«Quando è iniziata eravamo impreparati, totalmente, ad affrontare quell’emergenza: ci appoggiavamo su esperienze recenti, episodi influenzali trattati con antibiotici, ma non contavano e oggi sappiamo che l’unica linea di difesa è la vaccinazione, che non costa nulla e non comporta alcun tipo di pericolo se non in chi presenta problematiche allergiche. In ogni caso non ricordo un singolo caso, ricordo solo che in una settimana ci siamo visti travolgere. Ravenna, a differenza di Rimini, è stata risparmiata dalla prima ondata di Covid. Le vie di comunicazione, in questo caso, ci hanno aiutato ed il virus si è maggiormente diffuso lungo la via Emilia, dove l’impatto è stato devastante. Il punto è che questo virus presenta sintomi uguali a quelli di una banale sindrome influenzale virale e per distinguere chi avesse il Covid e chi no occorreva aspettare l’esito dei tamponi molecolari, che prima di tutto andavano implementati. I primi tamponi ci mettevano infatti anche un giorno e mezzo ad arrivare ed in quel lasso di tempo le persone dovevano rimanere in un pronto soccorso che doveva gestire non solo le urgenze in arrivo, ma che doveva anche lavorare sulla necessità di dividere gli spazi. Il pronto soccorso di Ravenna è un progetto nato in ritardo e basato su un concetto di open space, che è ottimo per gestire un grosso afflusso di feriti, ma in questo caso si doveva lavorare sulla separazione degli utenti. Al tempo proposi un progetto per poter allestire camere isolate trasparenti, ma poi si è optato per trasformare il presidio di Lugo in un Covid Hospital».
Come vi siete organizzati?
«Abbiamo dovuto liberare le Rianimazioni, dedicate al servizio interno, per destinarle a chi necessitava di un trattamento altamente intensivo ma non post operatorio. Entrò in campo il bisogno di avere reparti ad alta intensità senza però dover ricorrere ad una vera e propria rianimazione, di conseguenza abbiamo puntato alla medicina d’urgenza. Qui il lavoro, anche di riorganizzazione, è stato tantissimo. Il peso, per il personale, è stato anche quello di doversi vestire e svestire in continuazione per passare da una stanza ad un’altra e si è protratto per due anni».
Una difficoltà nella difficoltà...
«Il difficile di questa situazione non è stata tanto la patologia in sè, che andava assistita dal punto di vista respiratorio e generale per scongiurare eventuali complicanze, ma è stato tutto il resto. Mancava un contesto in cui poter fare tutto questo, cosa che ha comportato una serie di decisioni quale quella, ad esempio, di non far entrare i parenti dei pazienti».
Poi è arrivata la seconda ondata, come è stata?
«Se la prima ondata ci ha un po’ risparmiato, alla seconda le cose erano diverse. Il virus mutava e diventava più infettante, anche se le complicanze erano meno. Bisogna però pensare al nostro contesto, quello dell’Ausl di Ravenna, dove si concentra il maggior numero di grandi anziani di tutta la regione. Infine, essendo completamente mancata la risposta dei medici di base, tutti coloro che necessitavano di una risposta si sono riversati al pronto soccorso, ma è impossibile pensare che una realtà in cui lavoravano quattro medici potesse far fronte ad una richiesta come quella che abbiamo avuto. Oggi, però, alla luce di quanto è successo, dovremmo essere riusciti a produrre una risposta anche attraverso il reclutamento di maggiore forza lavoro».
Lavorare in prima linea non dev’essere facile...
«Tanti medici se ne sono andati: affrontare da soli l’80% del problema diventa svilente e tanti hanno detto che non erano più disposti a lavorare nell’urgenza. Abbiamo dovuto rimboccarci le maniche fino a che, come detto, ho chiesto l’attivazione del piano di emergenza e in quattro ore sono riuscito a svuotare diversi reparti indirizzando i pazienti negli ospedali di Lugo, Faenza e Forlì. Nessuno, però, è sceso dagli altri piani a dare una mano. Ci siamo dovuti inventare una risposta, ma nel farlo siamo stati soli. Un collega, che al tempo veniva dall’ospedale di Varese, ha raccontato invece di medici che dai reparti specialistici facevano guardie in pronto soccorso».
Che occorra investire sui medici di medicina d’urgenza lei lo sostiene da tempo...
«Sì, sono oltre vent’anni che lo dico, servono nuove politiche per chi lavora nell’urgenza e va riconosciuto lo status di lavoro particolarmente usurante perchè questo avvantaggia la carriera di una vita di guardie. Nell’ultimo anno ho fatto piu di 350 timbrature di cartellino e lo stesso hanno fatto i miei colleghi. Il tema rimarrà attuale sia che permanga il Covid, sia che la morsa si allenti, dal momento che a Ravenna le prestazioni pre pandemia si aggiravano sulle 300 al giorno».
 15:27
15:27 Nuvoloso
Nuvoloso  Accedi/Registrati
Accedi/Registrati


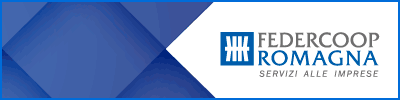















 Torna indietro
Torna indietro












































