Faenza, Grilli del «Teatro Due Mondi» racconta i laboratori «Senza Confini»

«Non devono diventare attori né artisti. Li aiutiamo solo a entrare in contatto con l’altro e a trasformarsi in cittadini». Alberto Grilli è il regista e il direttore artistico del «Teatro Due Mondi» di Faenza, la compagnia che a partire dal 2011 ha iniziato a proporre i laboratori «Senza confini» che ancora oggi coinvolgono italiani e migranti, molto spesso arrivati da poco. La prossima esperienza è appena partita e si intitola «Senza confini d’Europa», visto che il progetto è stato inserito in un bando regionale sulla cittadinanza europea. Come in tutti i precedenti casi, l’obiettivo è uno spettacolo all’aperto, per strada, che nel gergo della compagnia viene chiamato «azione»: «Nel tempo abbiamo realizzato azioni contro la guerra, per la pace, contro la quotidiana indifferenza. Si tratta sempre di momenti che cercano di coinvolgere un pubblico il più possibile ampio, che magari passa di lì per caso e che non necessariamente entrerebbe in un teatro». Il primo spettacolo in ordine di tempo, «Tra le onde del mondo», si tenne al Cas di Villa San Martino, nel Lughese, dove gli operatori avevano chiesto uno spettacolo per intrattenere i profughi ma dove il «Teatro Due Mondi», invece, aveva capovolto la proposta portando il primo laboratorio di teatro: «Di quel periodo ricordo molte cose: i volti dei quindici ragazzi, tutti provenienti dall’Africa, che dalla Libia si erano ritrovati all’improvviso su un barcone in mezzo al Mediterraneo e poi nella Pianura Padana. Ho bene in mente anche l’ostacolo della lingua, che però iniziammo immediatamente a superare, affinando via via il metodo di lavoro, che molto cominciò a basarsi su imitazione e ripetizione. Ricordo anche - e allora fu uno degli insegnamenti più importanti per me - che prendemmo a guardare sempre meno al gruppo e sempre più ai singoli individui. Perché se in un primo momento vedi degli africani, dopo inizi a distinguere tra chi è della Nigeria e chi della Costa D’Avorio e poi, via via, noti le differenze tra chi ha studiato e chi no, tra chi viene dalla città e chi dalla campagna. Insomma, si impara a concentrarsi sulle persone e le loro caratteristiche. Alcuni ragazzi li sento ancora, a volte sui social: qualcuno si è stabilizzato qui, altri sono in giro per l’Europa, altri ancora sono tornati a casa». D’altro canto, per i migranti, il teatro è sempre stato, nel corso degli anni, l’occasione per conoscere la gente del posto, gli stranieri di altri Paesi ma anche di capire i valori di riferimento della cultura occidentale: «Senza mai smettere di rispettare i loro riferimenti culturali e religiosi, abbiamo sempre proposto un percorso di conoscenza e rispetto reciproco non sempre semplice ma comunque di grande valenza. Penso, per esempio, ad alcune questioni sulle quali noi non possiamo cedere, come la parità di genere. Ma anche all’impegno messo sui diritti e i doveri legati al lavoro, sulla legalità, la giustizia, l’uguaglianza. Temi che il teatro ci aiuta a raccontare, a diffondere, a condividere». Non è facile, invece, coinvolgere le donne: «Mentre tra i non attori italiani sono la maggior parte, tra i non attori stranieri il 70% è composto da uomini. Le donne, forse per questioni culturali o per la presenza di vissuti molto pesanti, difficilmente accedono, anche se noi continuiamo a credere che le cose possano cambiare. Così come speriamo che il decreto Salvini venga modificato, che l’accoglienza diffusa alla quale anche questo territorio era abituato possa essere ripristinata. Al momento abbiamo a che fare più che altro con i minori seguiti da Zerocento e con i migranti che si sono fermati a Faenza o Ravenna. Non è facile proseguire questo lavoro ma noi andiamo avanti».
 10:06
10:06 Nuvoloso
Nuvoloso  Accedi/Registrati
Accedi/Registrati


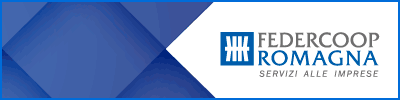















 Torna indietro
Torna indietro












































